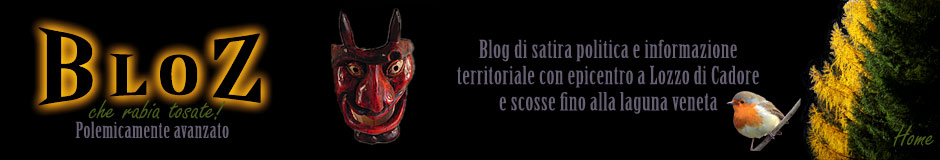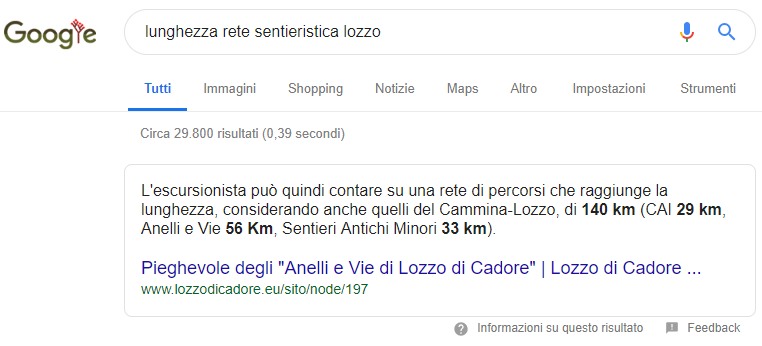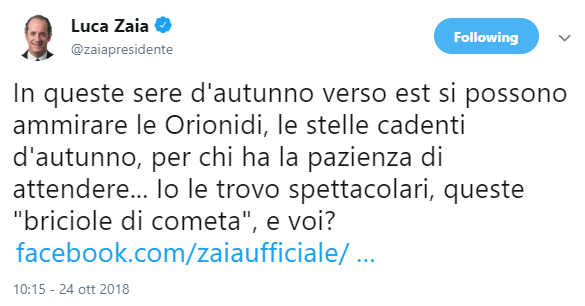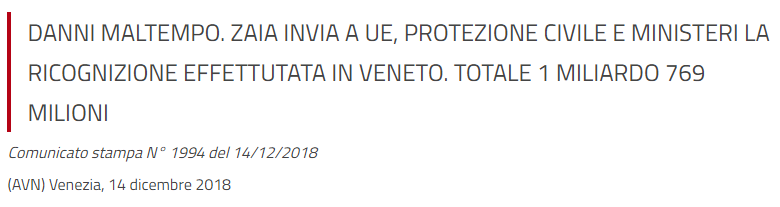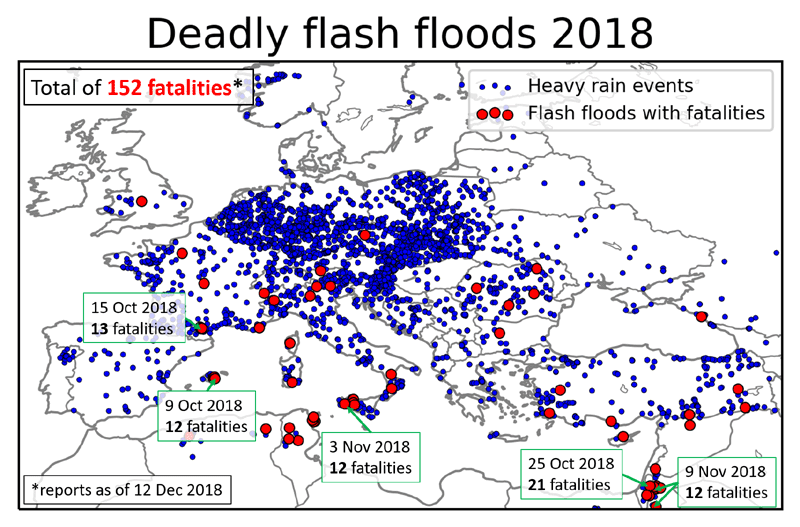PICCOLE NOTE STORICHE SUL MIO PAESE: LOZZO
(La superficie geografica del territorio di Lozzo è vasta poco più di 30 km2; tra i comuni centrocadorini non è quello meno esteso, posizione ricoperta da Lorenzago con 27 km2, ma viene subito dopo quest’ultimo; eppure, pur avendo quasi la stessa superficie, nel 1871 Lorenzago contava 1045 abitanti mentre quelli di Lozzo giungevano a 1875; e che dire di Auronzo che, con i suoi 220 km2, giganteggia su tutti ma che nel 1871 aveva 4500 abitanti? Una superficie 7 volte più grande di quella lozzese per una popolazione “solo” 2,5 volte più grande. Particolarità geografiche. Ancora: Lozzo è l’unico comune, con l’eccezione della Croda de San Laurenzo (poco più de n peron), a non avere sul proprio territorio una vera, signora montagna. In compenso può vantare Pian dei Buoi, uno dei due soli altopiani pascolivi (l’altro è Razzo) presenti nel comprensorio. Altre particolarità geografiche. Ma Lozzo ne ha altre ancora! In attesa di vederle raccolte un giorno da qualche parte, godiamoci allora le particolarità storiche che riguardano il nostro borgo ed il suo territorio che Giuseppe Zanella ha selezionato, raccolto e compendiato nel seguente scritto che si fa leggere tutto d’un fiato)
di Giuseppe Zanella
Alcuni studiosi affermano che in Cadore i borghi di Lozzo e Pozzale sono forse i più antichi centri abitati dell’intero comprensorio. Sulla etimologia del nome “Lozzo” i pareri risultano discordi. Giuseppe Ciani, ad esempio, ritiene che il nome sia dovuto a ‘Lucius’, probabile prenome di un romano che avrebbe stabilito la propria dimora su di un colle, da sempre definito come “Col di Tamber”, dove fino a non molti decenni fa si potevano ancora notare i ruderi di un presunto fortilizio, o torre, o castello; è verosimile che si trattasse di un punto di osservazione militare attorno al quale sorgevano certamente delle abitazioni, ossia delle primordiali baite. Gli scavi effettuati verso il finire del 1800 portarono alla luce, sui ruderi di quello che si riteneva ‘punto di osservazione militare’, un ingegnoso sistema di riscaldamento dato da un reticolo di cunicoli per il passaggio di aria o acqua calda, proveniente dalla combustione creata da una caldaia posta in un angolo della complessa costruzione. In fatto di scienza idraulica, insomma, i romani erano davvero precursori delle odierne e moderne tecniche di riscaldamento… Altri studiosi ritengono che la radice del nome sia la stessa della parola ‘luce’ e ciò in riferimento ai segnali che potrebbero essere stati usati in determinate situazioni e da ben individuati punti strategici al fine di avviso di allarme in caso di pericolo costituito da possibili invasori. La terza versione sulla etimologia del nome la fornisce il Prof. Antonio Ronzon accostando lozzo al nome ‘Lutetia’ (Parigi) e facendolo derivare da ‘luteum’ ossia ‘sito paludoso’. L’ultima ipotesi è che il nome faccia riferimento a ‘lucus’, bosco. Non sono escluse altre curiose interpretazioni o ipotesi, tutte però alquanto fantasiose e con un forte grado di opinabilità.
——————–
In antico il ‘vico’ di Lozzo non occupava l’area urbana odierna ma era strutturato in diverse borgate o frazioni poste in posizioni amene e più in alto rispetto all’attuale insediamento. Le antiche borgate erano: Vigo, Sale, Piaze de la Cross-le Spesse, S. Rocco. Sicuramente la borgata più importante era quella di “Piaze de la Cross-Le Spesse”, agglomerato che però andò completamente distrutto e sepolto dalla enorme frana del 25.1.1348, staccatasi dal Monte Mizzoi in conseguenza del devastante terremoto che provocò allora tanti lutti e rovine nell’intero Cadore e non solo. Diverse altre furono le motivazioni che determinarono l’abbandono delle altre frazioni, citiamo, ad esempio, le carenze nell’approvvigionamento idrico, le difficoltà nelle comunicazioni interfrazionali in particolare durante l’inverno, l’ulteriore pericolo di frane e smottamenti incombenti. Sale (l’odierna località di Sora-Sale) fu di sicuro abbandonata per la accentuata carenza d’acqua ed anche per il pericolo di distacchi rocciosi dal sovrastante costone di Sora-crode. Pericoli vari ed altre carenze di natura logistica contrassegnarono anche i casi che portarono all’abbandono delle altre frazioni. Ma allora dove i nostri progenitori ritennero di poter allocare il nuovo abitato? La soluzione migliore apparve subito quella di poter utilizzare l’area prospiciente il corso del medio-basso rio Rin, potendo così fruire per svariati usi delle copiose acque di quel torrente mai in secca.
Fu così che la tenacia, la laboriosità, l’intraprendenza e l’ingegnosità dei nostri avi consentì, con il trasferimento dell’agglomerato abitativo, anche la graduale creazione di un tessuto produttivo, lungo il corso del citato rio (dalla attuale borgata Da Rin alla località Ronzie), con l’instaurazione di opifici dalle più variegate destinazioni, sfruttando opportunamente l’energia idraulica di così copiose acque dalla portata costante durante tutto l’anno. Sorsero infatti una miriade di attività all’epoca impensabili nell’intero comprensorio, videro la luce mulini, tessiture per la lana e la canapa, folli per panni in genere, e poi segherie, falegnamerie, officine fabbrili ecc., il tutto cogliendo l’opportunità e la disponibilità della forza motrice idraulica di generosa derivazione dal “munifico”… monte Giastelin. A ridosso di questa zona artigianale-industriale ante-litteram, i nostri progenitori attuarono ed avviarono a realizzazione il nuovo piano di urbanizzazione civile con la costruzione delle abitazioni via via sostitutive di quelle abbandonate nelle antiche frazioni. Non fu questo processo di trasformazione né breve né facile. Alla fine, però, la lungimiranza dei nostri vecchi risultò premiata con il rio Rin divenuto elemento indispensabile allo sviluppo civile ed economico del paese ed alla creazione, qui prima che altrove in Cadore, di una classe imprenditoriale dimorante in prossimità del reticolo di opifici funzionanti grazie all’energia ottenuta mercé la vicinanza al torrente. Classe imprenditoriale, per quei tempi, unica ed essenziale non solo per il nostro borgo ma per l’intero circondario.
Mugnai, falegnami, fabbri, tessitori, titolari di folli, ‘segantini’, commercianti di legname, titolari di segherie dettero insomma slancio ed impulso al paese, che subito poté registrare un certo grado di benessere ed un contestuale incremento demografico. Con il consolidarsi di questa area produttiva e con il collaterale completamento della urbanizzazione, si ebbe un ulteriore impulso nella produzione di beni, servizi e derrate che consentì al nuovo ‘borgo’ di essere battistrada dello sviluppo economico dell’intero comprensorio centro-cadorino. Nel 17° e 18° secolo poi, le scoperte e la introduzione di basilari tecnologie in campo soprattutto ‘energetico’ gettarono le basi per un nuovo impulso produttivo derivante da investimenti infrastrutturali che segnarono il passaggio dallo sfruttamento idraulico della ‘ruota’ alla costruzione della prima primordiale centralina elettrica in località Ronzie. Pionieri nella introduzione della provvidenziale energia elettrica sarebbero stati i Baldovin Carulli, precursori in Centro Cadore in questo ambito tecnologico che avrebbe consentito la crescita del numero degli opifici e l’incremento esponenziale della loro capacità operativa ed imprenditoriale, nonché la introduzione della illuminazione interna alle abitazioni e, successivamente, l’instaurazione di un reticolo esterno, nelle vie del paese, per il trasporto dell’energia elettrica a scopo di illuminazione pubblica dell’intero abitato.
—————————
Si parlava all’inizio di ‘vetustà’ del paese; ebbene, essa è documentata dai molti rinvenimenti di reperti, a seguito di scavi archeologici promossi da vari benemeriti ed appassionati di storia locale (da citare, ad esempio, il maestro Francesco Barnabò, che dette fondo ai suoi risparmi per fronteggiare le spese necessarie, per poi dover desistere dal suo più ambizioso progetto di allargare il campo di indagine ad un’area più estesa sia nelle località di La Cross-Le Spesse che in località Cerchio, e ciò in assenza dei tanto richiesti e sollecitati interventi pubblici). Trattasi di rinvenimenti affiorati, in genere, nella seconda metà del 1800, in tutta una serie di scavi-occasionali (vedi approntamento di fondamenta per la costruzione di nuove abitazione) o sistematici (ad opera di esperti in archeologia e storia che avevano individuato specifiche aree di indagine); tutte queste ‘scoperte’ e questi rinvenimenti avevano ed hanno documentato la natura pre-romana del luogo. L’illustre storico, archeologo e glottologo G.Battista Pellegrini parla di Lozzo come di uno dei centri protostorici più importanti. Citando questa autorevolissima fonte ed anche altre minori, possiamo elencare alcuni dei più importanti rinvenimenti.
—————————–
In data 7.8.1853 il sacerdote Don Gio. Pietro Zanella stila una comunicazione per le pubbliche autorità centrali allegando un inventario, vidimato dalla deputazione comunale di Lozzo e controfirmato dall’ “agente comunale” (Segretario) G. Angelo Zanetti, nel quale sono descritti i doviziosi rinvenimenti a seguito degli scavi effettuati, per la costruzione di una abitazione, nel podere Baldovin Stefin, nella parte alta della Riva di Brodevin. Ci furono poi nel 1871 i ritrovamenti, a NE dell’abitato attuale, con lo scoprimento di tombe, a strati sovrapposti, in parte anche di origine pre-romana, oggetti di bronzo e ferro, un cippo funerario di ardesia e tanto altro ancora. Ci furono inoltre gli scavi, effettuati nel 1881, operati dal maestro Francesco Barnabò a Piaze de la Cross-Le Spesse e sul vicino col de Tamber, con il rinvenimento di oggettistica varia, in parte anche stavolta di origine pre-romana, di una moneta di argento databile al II° secolo a. Cristo e di tanto altro materiale. Sempre nel 1881, il Barnabò aveva fruttuosamente ripreso gli scavi a Brodevin ed in località Cerchio, rinvenendo uno scheletro e ben 13 tombe, coltelli, placche di cinture, spezzoni di lance, perle di vetro azzurrino, un orecchino di bronzo, lucerne di bronzo ed altro dovizioso materiale. La relazione per le autorità centrali questa volta fu stesa da mons. Gaetano Monti, parroco del paese ed arcidiacono del Cadore; nel suo scritto egli parla di decine di tombe documentanti la presenza di una autentica necropoli romana e di epoca anche antecedente. E la tesi sulla presenza in loco di una necropoli è sostenuta anche da uno studioso del calibro del già menzionato prof. G. Battista Pellegrini, glottologo, archeologo e storico di notorietà e valenza internazionale. L’intera area di Brodevin-Cerchio avrebbe meritato maggiore attenzione con il proseguimento degli scavi ma i fondi del Barnabò presto si esaurirono e le richieste di finanziamenti dal ‘Centro’ (leggi: sovraintendenza e ministero), nonostante le reiterate domande, rimasero lettera morta. Il copioso materiale rinvenuto fu poi fatto oggetto delle razzie austriache nel 1917, anche se, per fortuna, tutto era stato opportunamente catalogato, inventariato e fotografato per doverosa documentazione ai ‘posteri’.
————————-
Dalle epoche più remote e fino agli anni ’40/’50 del secolo scorso, la principale risorsa dei lozzesi era costituita dalla agricoltura intimamente collegata all’allevamento del bestiame ed alla pastorizia. Le attività di corollario (e/o indotte) erano poi quelle della fienagione, della attività di trasformazione lattiero-casearia e quelle dell’utilizzo razionale del bosco. Di particolare rilievo, in ordine all’allevamento del bestiame, risultava la transumanza con il trasferimento, nella buona stagione, degli animali (greggi di pecore e capre, ma soprattutto vitelli, manze e mucche da latte) nelle casere e stalloni sparsi sull’intero pianoro di Pian dei Buoi, altopiano provvisto di pascoli ubertosi, quanto mai idonei alla produzione sia di latte che di carne di ottima qualità.
————————–
Pian dei Buoi. Per convenzione, questo termine individua l’intero, ameno altopiano situato ai piedi delle Marmarole orientali. Il nome quindi individua non soltanto il “Pian dei Buoi” vero e proprio ma anche tutte le numerose contigue località ed il vasto complesso è stato definito dagli esperti naturalisti “una vera e propria perla paesaggistica e naturalistica” il cui valore viene arricchito e potenziato dalla vicinanza di una estesa area protetta immersa nella rete “Natura 2000”, definita ed individuata con il nome “Marmarole-Antelao-Sorapis”, area tutelata come sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale. Trattasi di un comprensorio dolomitico tra i più belli, forse il più bello dell’intero arco alpino. L’altopiano di Pian dei Buoi è composto dalle seguenti, principali parti: Sora Crepa, Campo di Croce, Colle Cervera, Mizzoi, Sovergna, Pian dei Buoi (propriamente detto), Col dei Buoi, Somol, Col Vidal e ancora tante altre località. Ad ovest del Pian dei Buoi vero e proprio, nella zona che fa da confine al censuario comunale di Lozzo, troviamo il Monte Ciastellin (con la sua omonima ‘cresta’), dal quale nasce il rio Rin affluente del Piave, provvidenziale torrente importante per l’economia del luogo, anche se le sue acque impetuose hanno creato non pochi timori nel corso di periodiche alluvioni (basti ricordare gli eventi paurosi del 1966 e del 2016; sarà per questo che i nostri vecchi, basandosi sulla conoscenza diretta della storia, dicevano che “il Rin, all’incirca ogni 50 anni, si fa sentire…”). Appena all’interno rispetto alla cresta Ciastellin, si possono notare: “Forcella s. Pietro” con nelle vicinanze il celebrato, magnifico “pupo di S. Lorenzo”, poi il “ Monte Ciareido” con ai suoi piedi l’omonimo rifugio (ora di proprietà comunale ed ormai di “pertinenza” del CAI, che lo ha dato in gestione a terzi quale ristorante); nell’ordine, troviamo infine “Forcella S. Lorenzo”, che termina nella splendida “Costa Pomadonna”.
A proposito di transumanza, va ricordato che l’altopiano e gli areali ad esso collegati annoverano ancora oggi diverse casere e casoni che un tempo ospitavano greggi e mandrie, pastori e boscaioli: Casera delle Armente (Casera de le Vace), Casone di Valdacene, Casone di Campiviei, Casone di Valsalega, Cason di Forcella Bassa. Vanno ricordate infine le Casere di Val da Rin, delle Fede e di Confin delle quali, tranne l’ultima citata che presenta ancora parte dei muri perimetrali, non sono rimasti visibili neanche i ruderi.
Va anche detto che l’altopiano faceva parte della linea di difesa “Cadore-Maé” con il sistema fortificato di Col Vidal (ora inserito nel ‘parco della memoria’) e la caserma di Sora Crepa intitolata all’eroe Montiglio.
Abbinato al fenomeno della transumanza, non bisogna trascurare di citare lo sfalcio dei prati d’alta montagna operato dagli agricoltori locali coadiuvati dai ‘segantin’ provenienti dalla provincia di Treviso. A questo proposito mi sovviene un ricordo di natura personale e famigliare. La ‘transumanza’ dei nuclei famigliari lozzesi durava tutto il mese di Luglio e buona parte del mese di Agosto e ci si spostava nelle varie località ‘punteggiate’ dalla presenza dei fienili per lo stoccaggio del foraggio. Anche la mia famiglia era inserita in questo contesto e l’ultima tappa del percorso della nostra personale ‘transumanza’ aveva proprio come destinazione “Pian dei Buoi”; esattamente a Sora Crepa, proprio davanti alla caserma Montiglio (a quei tempi ormai diroccata), esistevano cinque fienili, il primo dei quali era di proprietà di mio nonno paterno. Verso fine Luglio, da bambino, arrivavo con i miei per la fienagione su alcuni appezzamenti di proprietà di mio padre, ricordo come si dormisse sul fieno e la permanenza si protraesse per diversi giorni, mamma preparava i pasti all’esterno su di un rudimentale focolare fatto di sassi e con la ‘caliera’ appesa ad una catena, il tutto sostenuto da un palo conficcato nel terreno, i pasti erano costituiti da strane pietanze, alquanto miserelle in fatto di contenuti proteici, i cui nomi ricordo ancora con nostalgia: si trattava di ‘pestariei’, del ‘brofitto’ e della polenta con formaggio e latte.
Si dormiva nel fienile ed ho ancora presente la paura che provavo per i temporali notturni che incombevano su quell’anfiteatro dalle prominenti vette che attiravano i fulmini, con saette e tuoni impressionanti. Era comunque quello il tempo della mia fanciullezza, povera ma felice e spensierata, nonostante i predetti incubi notturni. Venne poi il cambiamento nella vita socio-econonica anche nel paesello, l’agricoltura decadde e lo sfalcio dei prati venne trascurato non solo alle alte quote ma anche in prossimità dell’abitato. Ed in quelli anni un incendio (non si è mai saputo se doloso o meno) fece scomparire quei cinque fienili dei quali resta comunque, quale documentazione, una foto ora facente parte del patrimonio delle tradizioni locali di un tempo. Nella immagine, scattata da mio padre, oltre ai fienili, si notano diverse lenzuola di canapa avvolgenti il fieno e, accanto, si intravvede l’immagine di Elio Calligaro Bedin ‘agghindato’ per la fienagione, appoggiato al rastrello.
Concludo queste modeste annotazioni ricordando i racconti che sentivo da ragazzo circa l’origine presunta del nome ‘Sovergna’. A Lozzo si diceva, nel buon tempo antico (e non si sa se si trattasse di leggenda o di fatto con alcuni elementi concreti di verità), che una nobile friulana, appunto di nome ‘Savorgnana’, possedesse sull’altipiano molti ‘acri’ di terreno e che, morendo, essendo innamorata del luogo e stimando i suoi abitanti, decidesse di lasciare come lascito ai lozzesi l’intera sua proprietà sita nel censuario comunale di Lozzo. Da allora, l’area avrebbe giustappunto assunto il nome della ‘presunta’ donatrice.